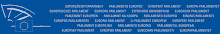Vini sì, ma senza mal di testa
La FDA – Food and Drug Administration americana ne ha proibito l’uso sui cibi da consumare freschi; anche in Svizzera e Australia alcuni solfiti non sono permessi. L’anidride solforosa contenuta nel vino (ebbene sì, in tutti i vini) può dar luogo a episodi classici come il cerchio alla testa, pesantezza o fenomeni allergici come l’asma. In Italia è l’unico antisettico permesso in enologia, anche nel vino da agricoltura biologica. Il suo limite massimo, nei vini destinati al consumo diretto, è di 220 mg/l. La sua presenza nei vini fino a qualche tempo fa non era assoggettata ad obbligo di etichettatura: a partire dal 2005, invece, è diventato obbligatorio riportare in etichetta (o nella retro-etichetta) in caratteri chiari, indelebili e sufficientemente grandi, la dizione “contiene anidride solforosa” o “contiene solfiti”, qualora nel vino venga superata la soglia di 10 milligrammi per litro (dose che scaturisce naturalmente nella fermentazione). Alcune prestigiose aziende vinicole biologiche certificate hanno deciso di escludere totalmente l’aggiunta di anidride solforosa nei processi di lavorazione e, grazie al recupero di tecniche alternative più sicure per la salute, abbinando sapientemente le più avanzate tecnologie con alcune pratiche tradizionali (quelle che si usavano prima dell’introduzione dell’anidride solforosa, e cioè fino a 50 anni fa) sono oggi in grado di offrire ottimi vini, sicuri sotto tutti i punti di vista, e senz’altro genuini. Vini che esaltano le caratteristiche dei monovitigni, il terroir, i profumi dell’uva e della cantina, ricchi di sostanze antiossidanti come tannini e vitamine, resveratrolo e sostanze minerali. Alcuni di questi produttori lavano addirittura le uve, abbattendo i contenuti di alcuni minerali pesanti.
Cosa consentono leggi e vari DD.MM.
Sono possibili vari metodi di concentrazione del mosto a caldo e a freddo, l’aggiunta di anidride solforosa o di metabisolfito di potassio e di disolfito di calcio, lieviti, bicarbonati, fosfati, acido tartarico e citrico, acidificazioni e disacidificazioni, aggiunta di enocianina e tannino (che hanno una drastica funzione astringente all’intestino), chiarificazione con gelatina, caseina e caseinati, albumine animali, demetallizzazione (che può lasciare residui pericolosi), aggiunta di mosti, di zucchero negli spumanti, di azoto, di enzima invertasi per trasformare il saccarosio in glucosio e produrre vini artificiali ritenuti regolari dal Ministero della Sanità, e poi (DM 12/3/1968) l’uso nel trattamento dei vini isosolfocianato di etile (essenza di senape) sciolta nella paraffina (che, per chi non lo sapesse, si estrae con solventi dal petrolio) e perfino l’uso (DM 879/1976) di enzimi pectolitici, che potrebbero essere impuri e che, se non usati correttamente, se oltrepassato il dosaggio consigliato o se non viene effettuata la filtrazione, possono formare alcol metilico (metanolo!). Altra pratica legale: aggiungere fermenti e zuccheri a vinacce scadenti. Addirittura, si può richiedere l’autorizzazione per la demetallizzazione (DM 5/9/1962): eseguire un trattamento con ferrocianuro di potassio che, se non eseguito a regola d’arte, lascia nel vino residui di ferrocianuri e acidoo cianidrico libero e combinato. Quest’ultima pratica però si scopre: deve essere indicata nelle fatture relative al prodotto o la data del trattamento e il nome del tecnico o la sigla del tecnico responsabile (2 iniziali maiuscole). Per elaborare il mosto concentrato rettificato, dal 1980 (DM 28/11/1989) si possono usare delle resine ioniche, con tali cautele che sembra si parli di nitroglicerina. Sofisticazioni: il record è di un americano che riuscì a vendere “vino” fatto con alcool denaturato (velenoso!) aromatizzato e colorato. Il vino si può invecchiare artificialmente con i chips dips, trucioli da infusione che riproducono il gusto del legno delle botti. La legge su DOC e DOCG (L. 10/2/1992 n. 164) è inapplicata. Anche i controlli latitano. Scrive Lionello Rizzati, decano dei Vigili Sanitari italiani: “per una vera vigilanza preventiva, l’esperienza insegna che i prelievi vanno intensificati ed eseguiti più negli esercizi di vendita che nei locali di produzione, perché raramente le frodi vengono perpetrate nei locali autorizzati. I fatti luttuosi del vino al metanolo sono un esempio di come si sia data la precedenza all’etichettatura più che al contenuto interno”. Come orientarsi? Ecco qualche buona regola da seguire. Sull’etichetta bisogna guardare chi e come ha prodotto e imbottigliato il vino. E’ bene orientare la scelta verso i vini i cui produttori coltivano le uve sui propri poderi, le mettono loro stessi in botte ed infine imbottigliano. Ciò si deduce da scritte quali: “imbottigliato all’origine da…” oppure “vinificato o imbottigliato da….” O “vino ottenuto da uve prodotte nelle proprie tenute e imbottigliato all’origine dal viticoltore”. Questo significa che, perlomeno, l’uva non compie passaggi strani, non viene raccolta da ogni dove, così come il vino non è trasportato in diversi luoghi (cioè controlli zero) prima di essere imbottigliato. Il produttore diviene così garante in prima persona della qualità del suo vino. Gli acronimi DOC e DOCG non hanno stretta attinenza con la genuinità e la bontà del vino, in sé, ma indicano la tutela del nome e del marchio associato a quel tipo di vino. Idem per l’IGT. Moltissimi fra i più costosi e pregiati vini italiani non sono DOC. Per garantire l’alta qualità dei loro prodotti, alcuni produttori hanno creato dei consorzi indipendenti, con una normativa interna e dei rigidi controlli, al fine di garantire alti livelli qualitativi per una fascia speciale di prodotti vinicoli, impedendo contraffazioni e sofisticazioni. Sull’etichetta la garanzia di questi prodotti appare con un piccolo logo, un simbolino, che comprende, generalmente, il nome del tipo di vino protetto o il metodo di vinificazione.