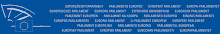MUSEO DEL VINO E DEL CAVATAPPI
I Musei Mazzucchelli*, allestiti nei suggestivi ambienti occidentali della settecentesca Villa neopalladiana di Ciliverghe di Mazzano, in provincia di Brescia, sono costituiti da quattro realtà espositive:

Nelle straordinarie Collezioni dei Musei, meritano particolare menzione rispetto al Museo del Vino e del Cavatappi: la Sala disegni incisioni e
Sala disegni incisioni e stampa
La collezione nasce parallelamente alla raccolta di cavatappi, strumenti per la vinificazione e la degustazione, costituita da Piero Giacomini a partire dagli anni Ottanta. Le incisioni, databili dal XVI secolo, si riconducono a diverse sezioni iconografiche: Mitologia e allegorie, immagini di Bacco, Baccanali, divinità minori e figure allegoriche connesse; Vendemmia e strumenti per la vinificazione, scene di vendemmia, immagini di strumenti per la vinificazione oltre a tavole enciclopediche e tavole botaniche; Il vino e la convivialità, scene di genere legate al consumo del vino, feste, banchetti; Bibbia e letteratura, immagini ispirate alle Sacre Scritture e altri fonti letterarie; Arte e incisione, incisioni che riproducono opere d’arte, per lo più dipinti e sculture; Pubblicità, immagini pubblicitarie di prodotti enologici del XX secolo. Tra le più significative: Maestro del Dado, Baccanale 1532 ca.; Agostino Musi detto Agostino Veneziano, La Marcia di Sileno, 1531-1535; Hubert Goltzius, Sine Cerere et Baccho Friget Venus, 1560 ca.; Philippe Galle, Baccanale, fine XVI – inizio XVII sec.; Johann Theodor de Bry, Trionfo di Bacco, primo quarto del XVII sec.; Francesco Villamena, Sileno ebbro, primo quarto del XVII sec.; Giovanni

Collezione di Cavatappi
La varietà dei pezzi è davvero sorprendente: si ritrovano i cavatappi preziosi degli aristocratici o delle dame che li ponevano sulle loro toilette con i profumi, le borsette e i ventagli; i cavatappi ingegnosi con vari meccanismi per facilitare l’uomo nello sforzo fisico e i cavatappi decorati con arte e creatività da artigiani, dove la fantasia e l’ironia la fanno da padrone. Ambra, madreperla, avorio, smalti, oro e argento sono solo alcuni dei materiali preziosi con cui sono stati realizzati…
Una selezione di circa cinquecento pezzi della preziosa collezione è stata recentemente pubblicata in un catalogo edito da Skirà, curato da Ottilia Munaretti Bertazzo, collezionista e studiosa dell’Associazione Italiana Collezionisti Cavatappi, in cui si dà testimonianza estetica e simbolica della qualità della vita negli ultimi tre secoli di storia.
I SEZIONE
L’ARISTOCRAZIA DEI CAVATAPPI
Cavatappi realizzati con materiali preziosi comparvero nella storia di questo strumento fin dalle origini. Gli esemplari qui illustrati sono sorprendenti sia per la bellezza della forma, sia per la raffinatezza nella lavorazione, tanto che possiamo considerarli dei veri gioielli. Abili artigiani, orafi o argentieri li realizzarono con materiali preziosi su commissione di aristocratici o di alti prelati. Molto spesso sono personalizzati con le iniziali o lo stemma nobiliare del proprietario. Sono tutti del tipo semplice a T o tascabili, con custodia cilindrica del verme, in oro o argento che si avvita alla parte inferiore del fusto. Il manico, generalmente a forma di piccolo barile affusolato, è in avorio, argento, madreperla o pietra dura. Stappavano bottiglie di vino, essenze di profumi o flaconi di medicine per cui ogni nobildonna ne conservava uno nel suo nécessaire da viaggio o sulla sua toilette. Spesso sono dotati di fischietto o di una lente o di altri attrezzi utili come forbici, acciarino, curapipe per accompagnare i gentiluomini a caccia, in carrozza o nelle campagne militari. Nelle taverne, dove sostavano durante i loro viaggi, i gentiluomini non bevevano il vino dei tavernieri e quindi utilizzavano i personali cavatappi, indice del loro rango, per aprire bottiglie di vino.
II SEZIONE
IL GENIO NELLA SEMPLICITA’
I primi cavatappi creati in Inghilterra dopo l’imbottigliamento delle bevande, sono i cavatappi semplici, detti a T. Senza meccanismi e composti di manico, fusto e verme, sono rimasti immutati nei secoli anche se i soggetti delle decorazioni hanno seguito l’evoluzione del gusto. Consentono di estrarre il tappo esclusivamente mediante trazione normale, per cui spesso si è cercato di adattare il manico o impugnatura all’anatomia della mano. I materiali più utilizzati per la costruzione del manico sono il legno di bosso o di noce, il ferro, l’osso, l’avorio, l’ottone e l’argento. Dalla fine del XVII secolo e per tutto il XIX, il manico fu spesso arricchito da uno o più accessori: lo spazzolino in setole di maiale per spolverare le etichette e togliere i detriti di ceralacca e lo sperone o falcetto per tagliare i fili che trattenevano il tappo sulle bottiglie effervescenti. Il fusto che collega il manico al verme, è realizzato con la stessa verga metallica ed è in ferro, a volte tornito o sfaccettato. Il verme, come osserverete negli esemplari esposti, può essere “a vite di Archimede” o a filo elicoidale detto anche “a coda di maiale”. A partire dalla seconda metà dell’ottocento, nell’Europa continentale, si diffonde anche il verme di acciaio con nucleo centrale pieno e filettatura tagliente.

III SEZIONE
L’INGEGNO NEI CAVATAPPI A MECCANISMO
Fin dal XVIII secolo l’uomo si impegnò nella ricerca di meccanismi da applicare al cavatappi per diminuire lo sforzo fisico nella fase di estrazione. Il primo meccanismo fu quello di applicare una campana aperta o chiusa che, facendo contrasto sul collo della bottiglia trasformasse la forza di rotazione in forza di estrazione del tappo. I primi esemplari sono francesi del XVIII secolo, chiamamti “Tire bouchon à cage”. Questo meccanismo a semplice rotazione ebbe nell’ottocento grande successo, soprattutto in Italia dove gli artigiani ne produssero diversi tipi con campana aperta in ottone, fusto in ferro e manico in legno tornito. Alcuni esemplari hanno il manico o macinino. Si inventò poi il meccanismo a pignone e cremagliera e il meccanismo a vite, spesso con manico a farfalla e campana aperta a due o quattro colonne. Grande successo, soprattutto in Francia ebbe il meccanismo a leva singola. Ad esso si ispirerà nel 1883 il tedesco Carl Wienke che brevettando in Inghilterra e in America il
suo modello monoleva dette ai sommeliers e ai camerieri uno strumento di lavoro pieghevole e tascabile, prodotto ancora oggi col nome di “cavatappi da cameriere”. Nel
IV SEZIONE
ARTE E CREATIVITA’ NEI CAVATAPPI
A partire dal XIX secolo gli artigiani, superata la fase iniziale di pura invenzione, svilupparono molto la decorazione soprattutto nel manico dei cavatappi del tipo semplice. Sono per lo più decorazioni ispirate all’uva e al vino: foglie, grappoli, tralci, bacco e satiri. I Francesi preferivano i soggetti erotici, i Tedeschi le gambe femminili con stivaletti e calze a righe colorate oppure sirene dalle forme arrotondate e dalla romantica chioma. All’inizio del XX secolo, seguendo le nuove tendenze artistiche dell’Art Nouveau prima e dell’Art Déco poi, ci fu una vera esplosione del tema figurativo con animali, soprattutto cani e gatti, pesci, chiavi, pistole ecc. Negli U.S.A. il promotore del proibizionismo (dal 1919 al 1933) il senatore Volstead è rappresentato come figura che ammonisce, ma che nasconde fra gli abiti il cavatappi. Tutti i personaggi della società sono poi rappresentati negli esemplari noti con il nome di “pisseux”: i poliziotti, i marinai, gli spazzacamini, i vignaioli, ecc. A scapito spesso della qualità dei cavatappi, gli artigiani vi profusero tutto il loro senso artistico, i loro sentimenti e a volte la loro ironia.