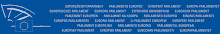Energia e agricoltura
Problemi e prospettive delle fonti rinnovabili
Per poter meglio apprezzare il ruolo delle energie rinnovabili in generale, e in agricoltura in particolare, è doveroso svolgere, anzitutto, qualche breve richiamo della storia recente. Questa la premessa della prolusione, sul tema delle fonti rinnovabili, con cui ha esordito il professor Giuseppe Pellizzi, dell’Università di Milano, il 21 febbraio presso la sala dello Stabat Mater nello storico Palazzo dell’Archiginnasio a Bologna, in occasione dell’inaugurazione del 198° anno dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
Fu a partire dall’autunno del 1973, infatti, che si avvertì per la prima volta il problema energetico a livello mondiale, in seguito alla crisi dello “Yom Kippur”, che fece rapidamente balzare il prezzo del greggio da 1,5-
In tal modo problemi di costi e problemi ambientali vennero a sovrapporsi e si cominciò, almeno da parte dei Paesi più avvertiti e consapevoli del problema, a studiare tutta la materia, a valutare il ruolo che avrebbe potuto essere giocato dall’agricoltura, a dibattere l’opzione offerta dall’energia nucleare, a esaminare le possibilità offerte dalle energie rinnovabili basate, in quanto pulite, rispettose dell’ambiente e sicure per gli esseri viventi, sull’energia fornita - direttamente o indirettamente - dal sistema solare. «Si pensi al sole come fonte di onde elettromagnetiche e di fotoni», ha spiegato il professor Pellizzi, «che ci riscaldano e ci danno la luce e che, al contempo – tramite la fotosintesi - fanno crescere le piante le quali, a loro volta, immagazzinano energia da legame chimico. Ma si pensi anche ai venti, ai corsi d’acqua, alle maree e al moto ondoso dei mari: tutte energie solari indirette (o gravitazionali), in grado di mettere a disposizione dell’uomo energia meccanica, elettrica e termica. Si pensi ancora all’energia geotermica, ossia al calore recuperabile, posseduto da rocce, umide o secche, poste all’interno della terra. E si pensi infine, riscoperto recentemente, all’idrogeno, che è la più grande risorsa energetica del pianeta».
Qualche anno più tardi, in pratica a partire dal “vertice sulla terra” dell’ONU (Rio de Janeiro 1992), si cominciò a coniugare il problema della tutela dell’ambiente con quello dello sviluppo socio-economico – strettamente legato agli aspetti energetici - dei vari Paesi. I partecipanti a quel vertice – mentre ammisero la crescente “fame” di energia per i fabbisogni delle varie società - convennero di dover attuare cambiamenti sostanziali per soddisfare le esigenze in materia di sviluppo di tutti i Paesi senza compromettere il futuro.
Ormai, entro il 2012 occorrerà sicuramente portare il contributo delle energie rinnovabili al 15% almeno del totale degli attuali consumi mondiali, stimati nell’ordine di 9.000 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), ma suscettibili forse di raggiungere i 14.000 Mtep/anno nel 2020, con un aumento, quindi, che interesserà i Paesi in via di sviluppo per circa il 60% del totale.
Ora, il principale problema delle energie rinnovabili è rappresentato dal funzionamento rigido nel tempo (il sole, ad esempio, c’è quando c’è, e così il vento). Da qui l’esigenza, per non dover ricorrere a dispendiosi sovradimensionamenti e a sistemi di accumulo, di supplire l’energia necessaria mediante “sistemi energetici integrati”, cioè sistemi composti da due o più fonti rinnovabili in funzione della specifica domanda (elettrica e/o termica) delle aziende. «Probabilmente la soluzione vincente sarà quella di produrre energia elettrica per la rete nazionale e/o energia termica a servizio di realtà esterne alle singole aziende agricole (tipo teleriscaldamento) – ha commentato il professor Pellizzi. Una tematica di grande attualità in un mondo globalizzato, dove le risorse energetiche tradizionali si stanno velocemente esaurendo e dove l’esaurimento delle scorte è ancor più rapido alla luce dei dati sui consumi della Cina, la cui domanda energetica è quasi raddoppiata nell’ultimo decennio e sarà, entro il 2020, analoga a quella degli USA. Tutto questo mentre il gas naturale mostrerà crescenti consumi a scapito del carbone, mentre assai incerto è il futuro del nucleare».
Quel che è indubbiamente interessante, è rilevare la stretta interdipendenza che sussiste fra energia, ambiente e agricoltura. La produzione agricola, infatti, è in grado di contribuire seriamente alla chiusura del circolo energetico-ambientale. Sussisterebbe quindi la possibilità di far vivere meglio la gente di tutto il pianeta senza che l’arroganza, la presunzione o la prepotenza di qualche Paese possano dargli il diritto di disporre degli altri a proprio piacimento e nel suo esclusivo interesse. Tutto ciò è fattibile con idonei investimenti in agricoltura a fini energetici e con la disponibilità di tecnologie appropriate, sul cui sviluppo bisogna ancora attivamente operare, a difesa dell’ambiente, cioè del mondo nel quale tutti noi viviamo. Si è accennato, prima, alla differente elasticità di funzionamento delle varie tecnologie emergenti. Vale, quindi, la pena di giustificare quanto detto – acquisito che numerose e varie sono le possibilità di impiego delle energie rinnovabili – nel quadro di una loro razionale utilizzazione in agricoltura. Due, infatti, sono le condizioni nelle quali ci si trova: da un lato il tipo di domanda energetica propria delle singole realtà, variabili in funzione degli ordinamenti praticati, della presenza o meno di animali in allevamento, nonché di impianti post-raccolta, di officine aziendali, ecc.; dall’altro, del fatto che la maggior parte delle energie rinnovabili presenta un funzionamento rigido nel tempo.
Se si facesse ricorso a una sola fonte energetica non elastica, questa dovrebbe essere dimensionata per coprire le punte di richiesta, ciò che non sarebbe se si ricorresse a due o più fonti complementari, una delle quali caratterizzata da un funzionamento di tipo elastico. «La cosa, quindi, si complica un po’», ha puntualizzato Pellizzi, «ed è questa la ragione per cui probabilmente la soluzione vincente sarà quella di produrre energia elettrica per la rete nazionale e/o energia termica a servizio di realtà esterne alle singole aziende agricole. Conseguentemente, occorre pensare alla nuova figura degli agricoltori produttori di energia per la collettività. In questa vasta e complessa problematica tutti noi abbiamo un ruolo importante da giocare sia all’interno del nostro Paese, sia nei riguardi dei Paesi terzi che devono essere aiutati a svilupparsi. Un ruolo scientifico, tecnico, economico, umanitario e politico tanto più impegnativo se si considera il problema dello sviluppo sostenibile con riferimento all’attività primaria. Da qui la crescente esigenza di definire tecnologie e sistemi altamente innovativi e appropriati al servizio di un’agricoltura atta a fornire prodotti di elevata qualità e salubrità. Il mondo agricolo si trova oggi di fronte a una nuova fase di grande complessità. Esso deve, al contempo, guardare al suo interno e al suo esterno pensando, per far fronte alle crescenti richieste alimentari del mercato planetario, a uno sviluppo che aumenti – ove necessario - le rese nazionali con l’uso di mezzi di produzione appropriati, così da ridurre l’inquinamento, produrre energia e soddisfare le esigenze alimentari della popolazione: come a dire, l’esigenza di incamminarsi lungo un percorso di sostenibilità economica e ambientale per tutti. Credo – ha così concluso il professor Pellizzi - sia necessario che enti scientifici come questa Accademia si facciano carico, eventualmente assieme agli altri sodalizi aderenti all’U.N.A.S.A., di promuovere una vasta azione di ricerca applicata, capace di conseguire in tempi relativamente brevi risultati validi, trasferibili, utilizzabili economicamente. Senza dubbio questo è un compito difficile ma, se non ci daremo da fare, c’è il pericolo che si avveri quanto scritto nel titolo di un’acquaforte di Goya, e cioè che… “il sonno della ragione generi mostri”».
… E pensare che già nel 1870 Antonio Pacinotti aveva tenuto, proprio in questa sede accademica, una interessante lettura sulla possibile utilizzazione del calore solare…
a cura di