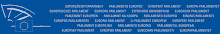La Compagnia dei Vignaioli del Monferrato sarà presente all’incontro dei mille vignaioli europei riuniti nel fine settimana a Montpellier per discutere del futuro della viti-vinicoltura europea minacciata dall’effetto globalizzazione. Il Presidente Domenico Ravizza contribuirà al dibattito con un documento approvato dall’Assemblea dell’associazione.
Portare a Montpellier mille vignaioli europei per dire no alla OCM vino in procinto di essere approvata da Bruxelles. E’ l’obiettivo di Slow Food ideatore dell’incontro che si svolgerà il 14 e 15 aprile, presso il centro congressi di Montpellier, titolato Vignerons d’Europe, in concomitanza con Salon du Goût et des Saveurs d'Origine, organizzato da Slow Food France. Il confronto tra mille vitivinicoltori di tutta Europa si rende necessario per le pressanti sfide imposte da un mercato sempre più condizionato dalla globalizzazione. L’incontro cade nel centenario della rivolta dei produttori di vino in Languedoc e Roussilion del 1907, e ciò significa aprire il dibattito sull’attuale crisi viticola che non è solamente economica, ma soprattutto identitaria. La OCM vino tende, come tutti i provvedimenti di carattere comunitario a privilegiare le grandi concentrazioni economiche, le grandi aziende, e la conseguente cancellazione delle piccole produzioni (anche di nicchia – termine stra abusato ma in questo caso necessario) che hanno invece identificato il nostro Paese soprattutto nel settore agro-alimentare. Per la Compagnia dei Vignaioli del Monferrato nel fine settimana di Montpellier ci sarà il Presidente Domenico Ravizza, il quale porterà con sé un documento da presentare e discutere all’incontro, approvato dall’Assemblea dei soci. In esso si paventano gli effetti di una politica comunitaria che cancellando le piccole aziende porterebbe alla scomparsa dei vigneti nelle aree collinari più disagevoli sul piano dell’organizzazione del lavoro. Per un’area come quella del Monferrato Casalese dove vivono e lavorano i vignaioli della Compagnia, ciò significherebbe una profonda trasformazione del territorio dal punto di vista ambientale, sociale, paesaggistico, di assetto idrogeologico. Sul piano agronomico, infatti, far scomparire la vite dalla collina, significa l’avanzare del campo e delle arature profonde per “una cerealicoltura comunque perdente” – recita il documento della Compagnia dei Vignaioli – e il conseguente proliferare delle frane. Dal punto di vista sociale significa la scomparsa delle piccole aziende, dell’occupazione; sul piano economico è invece la catastrofe per il tessuto aziendale-produttivo, per territori che negli anni hanno accumulato credibilità ed immagine sul piano del turismo, della qualità della vita e dei prodotti della terra.
12 APRILE 2007
Documento di sintesi delle mozioni da apportare alla discussione sulla proposta della commissione agricoltura sull’ OCM vino.
La viticoltura in Piemonte trova profonda correlazione con la cultura e la storia delle popolazioni che vi vivono ed ha determinato, nel corso di molti secoli, modificazioni consistenti nell’architettura del paesaggio dell’intera regione. Dopo aver visionato e discusso la proposta della commissione europea riguardo alla linee guida della futura Organizzazione Comune di Mercato, la Compagnia dei Vignaioli del Monferrato, pur comprendendo l’esigenza di affrontare le mutate situazioni dell’economia dell’Unione, e le forti pressioni politiche esercitate da lobby di potere, esprime il disappunto quasi totale sulla iniziativa di programmazione vitivinicola che si intende ratificare. Ovviamente il nostro contributo si riferisce ad una situazione e ad un territorio in cui i Vignaioli della Compagnia operano e producono ma che riteniamo, per tipo di lavoro ed obbiettivi, simili in caratteristiche e problematiche ad altre realtà in cui operano i Vignaioli d’Europa. L’aspetto sconcertante del documento programmatico della OCM è che dopo una prefazione in cui si magnificano le produzioni e la storia della viticoltura Europea, di fatto la si voglia ridurre ad un becero calcolo economico di opportunità e di capacità “industriale” ed individuando nella competitività all’interno del mercato globale l’obiettivo principe da perseguire.
L’obbiettivo, neppure molto nascosto, sembra sia quello di trasformare la viticoltura europea massificandone le produzioni, e concentrando l’offerta di prodotto ad un numero di soggetti notevolmente inferiore all’attuale. Tutto ciò consentirebbe, certamente, un maggiore controllo delle produzioni ed una rapportazione meno dispersiva e più snella con il mondo agricolo. Porterebbe però, ben presto, alla distruzione di quelle viticolture di collina impegnative ed a produttività medio bassa da sempre prime artefici della produzione di uve di pregio. Gli effetti di questi cambiamenti non si avvertirebbero solo in un appiattimento dell’offerta a favore di vini più uniformi e meno figli dei territori vocati che sino ad oggi ne sono stati i padri, ma comporterebbero l’abbandono di interi territori, oggi eroicamente coltivati. A quel punto i vigneti abbandonano le colline, tutto diventa campo, cambia il metodo di coltivazione, dominano le arature profonde per cavare da un terreno inadatto il nutrimento che non c’è per una cerealicoltura comunque perdente. Prima conseguenza di tutto ciò è il mutare delle condizioni di assetto idro-geologico; ci saranno più frane. E poi, addio ai bei panorami vitati che sono uno dei fondamenti del turismo rurale; e ancora addio al sogno di ricreare un tessuto economico sostenibile nei piccoli paesi, grazie al vino, ai prodotti tipici, al piccolo artigianato, al piccolo commercio bottegaio. Le colline tornerebbero a spopolarsi, e questa volta definitivamente. Parrebbe che il documento abbia l’obbiettivo di stravolgere tutto ciò che, negli anni passati, è stato fatto di buono. Alcune realtà anche attraverso le contribuzioni dell’Unione europea hanno potuto crescere e migliorare la qualità delle produzioni. I contributi per la conduzione e la gestione dei terreni, le produzioni ecocompatibili, la costituzione di gruppi professionali che indicavano controllavano e promuovevano innovazione nel rispetto dell’ambiente, una migliore concezione dell’ambiente di lavoro e del territorio, la possibilità di riprodurre e migliorare le produzioni autoctone (o storiche), la possibilità di insediare e far proseguire il lavoro di Vignaioli a moltissimi giovani che con entusiasmo e nuove idee hanno realizzato percorsi anche difficili come quelli delle produzioni biologiche, sono solo alcuni esempi degli enormi risultati pratici che sono stati ottenuti. Anche volendo ridurre le risorse di contribuzione, anche volendo rivedere il metodo, non si possono perdere di vista i pochi obbiettivi che si sono raggiunti. Il mantenimento ed il miglioramento professionale di molti giovani Viticoltori va rafforzato e stimolato attraverso percorsi che possano rendere merito a produzioni “uniche” e far si che anche piccole ma peculiari produzioni possano essere apprezzate in tutto il mondo. Occorre quindi, dare un segnale di “forte rispetto” per la terra che coltiviamo, a volte in giaciture difficili, di collina o di montagna. Ed ora mentre le Viticolture del “nuovo mondo” stanno rivedendo le loro politiche vitivinicole avvalendosi dell’esperienze Europee degli anni 90, noi andiamo a copiare le viticolture industriali dell’Australia che si sono dimostrate e si dimostrano sostanzialmente valide solo per riuscire ad offrire un prodotto “omologato” e abbastanza piacevole a basso prezzo. Su una cosa ci si trova concordi, nel voler ridurre ed azzerare in poco tempo le contribuzioni all’utilizzo del mosto concentrato, e nell’azzerare le contribuzioni allo stoccaggio ed alla distillazione dei vini. Certamente queste operazioni porteranno ad una riqualificazione ed a una riduzione delle produzioni per ettaro (e di conseguenza alla produzione totale) migliorandone notevolmente le medie qualitative e portando la viticoltura a non appiattirsi indirizzandosi su produzioni a basso costo e quindi a basso prezzo (già ora sono evidenti le preoccupazioni delle grandi lobby che lucrano sull’alcol e sugli zuccheri). Almeno una parte delle risorse così risparmiate potrebbero incentivare le produzione ecocompatibili, fornendo i mezzi professionali per poter meglio contrastare le avversità della vite siano esse fungine, virali e quantaltro, o potrebbero consentire anche a piccole produzioni di proporsi ai consumatori del mondo presentando le grandi meraviglie della Viticoltura Europea. Il nostro vino e le nostre vigne, nelle colline del Monferrato Casalese, non debbono ridursi o sparire solo perché il programma prevede l’estirpo di centinaia di migliaia di ettari di vigneto; a farne le spese e ad essere abbandonate sarebbero sicuramente le vigne migliori, le più vecchie e quelle poste sui versanti più erti e qualificati alla produzione di uve di pregio.